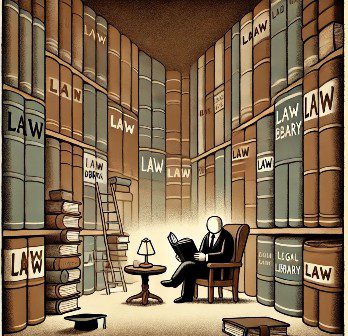Dietro la Sentenza
La sentenza arrivò in una giornata di pioggia. Di quelle che rendono ancora più cupo il marmo umido dei tribunali e spingono i cronisti ad aprire l’articolo con qualcosa tipo “Il cielo sembrava riflettere lo stato d’animo del Paese”. Colpevole, disse il giudice. Sedici anni e otto mesi. La folla fuori imprecò, i talk show montarono in diretta, Twitter esplose. Tutti avevano qualcosa da dire sul giudice: incompetente, venduto, coraggioso, disumano, dipendeva da che parte stavi.
Dell’avvocato difensore, non parlò nessuno.
Eppure era stato lui, con l’ostinazione di un rabdomante, a trovare nei meandri di un codice dimenticato quella crepa giuridica da cui era entrata, silenziosa, la possibilità di una pena ridotta. Aveva passato notti su notti a smontare perizie, cercare precedenti, cucire una linea difensiva come un sarto nevrotico. Ma nel racconto pubblico, l’Avvocato era stato un accessorio del processo. Un’ombra con la toga.
Non è un caso isolato. Quando una sentenza suscita scalpore, l’attenzione si concentra sempre e solo su chi la firma. “I giudici hanno deciso”, si dice. O, più spesso, si urla: “I giudici sono matti”. O peggio: “I giudici sono comunisti”, “sono servi dello Stato”, “sono la rovina dell’Italia”.
Nel frattempo, l’avvocato difensore — che ha passato l’intero processo a costruire la narrazione giuridica su cui si basa la decisione, che ha passato notti insonni, che ha combattuto con se stesso e con l’ansia — viene ignorato come il fonico durante un Oscar.
Il problema è, in buona parte, comunicativo. I media semplificano. Hanno bisogno di protagonisti, di antagonisti, di colpi di scena. E il giudice è perfetto: ha l’autoritas, ha la toga, ha il potere di dire “colpevole”. È lui, per il pubblico, a “scrivere la fine del film”.
L’avvocato, invece, lavora nel mezzo.
Fa il lavoro sporco della trama. Nessuno applaude lo sceneggiatore quando muore l’eroe. Vogliono sapere chi ha scelto il finale, non chi l’ha preparato.
C’è anche una questione più profonda, quasi antropologica. Il giudice viene percepito come il sacerdote della giustizia: neutrale, freddo, distante. L’avvocato, al contrario, è visto come un soldato mercenario. Difende chi lo paga.
Questa percezione è il frutto di un bias cognitivo: crediamo che il giudice incarni la morale, e che l’avvocato ne sia il contraltare utilitarista. Ma in realtà, il giudice applica norme. L’avvocato interpreta possibilità. E il processo — grande assente nella coscienza collettiva —
non è un’arena etica, ma un congegno logico.
Quando una sentenza sorprende o delude, le persone reagiscono cercando un colpevole. Ma la legge non funziona secondo la logica del “giusto/sbagliato morale”, ma secondo norme, interpretazioni e precedenti. Questo mismatch tra legge e percezione popolare fa scattare la rabbia verso chi “ha firmato”, cioè i giudici.
Ed è proprio questo il nodo: il processo non è fatto per dare conforto morale, ma per garantire razionalità giuridica. Funziona come un algoritmo vecchio stile: input (le prove), parametri (le leggi), output (la sentenza). Ed è così da centinaia di anni, anche nei testi dell’inquisizione fondati sulla “morale” c’era la logica e la procedura.
Ma il pubblico vuole giustizia morale, non giustizia legale. Quando sente che qualcosa “non torna”, cerca un responsabile. E lo individua facilmente nel giudice, perché è lui a “decidere”. L’avvocato, invece, viene percepito come un fattore esterno. Uno che ha fatto il suo, ma che non ha davvero inciso.
Paradossale, perché spesso è proprio la strategia difensiva a plasmare l’intero corso del processo.
Nel nostro caso, ad esempio, fu proprio l’avvocato a suggerire la derubricazione del reato in un’udienza preliminare che nessuno si prese la briga di coprire. Lo fece con una memoria di 37 pagine, piena di riferimenti a sentenze della Cassazione, interpretazioni europee, obiter dicta dimenticati. Un lavoro certosino, chirurgico. Eppure, alla fine, sui giornali non fu nemmeno citato.
Il motivo?
La sua tesi era troppo tecnica per essere trasformata in storytelling.
Nessuno vuole leggere un post su Facebook che inizi con: “Secondo l’interpretazione estensiva dell’art. 131-bis c.p…”. Si preferisce dire: “Il giudice ha graziato l’imputato”. Come se fosse un atto arbitrario, e non l’esito di un incastro giuridico.
Nel racconto mediatico serve un “colpevole” o un “eroe”. Il giudice è l’autorità che “decide”, quindi è facile e immediato associargli il merito o la colpa.
Un altro fattore che alimenta l’invisibilità degli avvocati è la dimensione pubblica del giudice. Il magistrato rappresenta lo Stato. Viene pagato dallo Stato, parla per conto dello Stato.
Percezione sociale del ruolo (psicologia collettiva)
Quando la sentenza delude, è naturale che la frustrazione collettiva si riversi su di lui. L’avvocato, essendo privato, sfugge al radar della responsabilità pubblica. Viene quasi visto come un consulente: uno che “fa il suo lavoro”, ma che non ha voce nel risultato.
In realtà, non solo ha voce: spesso ha l’intero copione in mano.
Esiste, certo, anche una responsabilità della categoria. Troppo spesso gli avvocati si ritraggono, parlano solo tra loro, non partecipano alla costruzione del racconto giuridico nel discorso pubblico. Preferiscono i convegni ai microfoni, le riviste specialistiche ai social. Il che è comprensibile, ma non aiuta. Perché finché il processo verrà raccontato solo alla fine, con una sentenza, il ruolo dell’avvocato resterà un mistero per chi guarda. La spiegazione resterà in balia di
ignobili commentatori dediti alla semplificazione e al clickbait
C’è però un altro problema, ancora più a monte: l’idea che la giustizia sia una cosa “semplice”. Che basti sapere chi ha torto e chi ha ragione, come se fossimo in un racconto biblico. Ma la giustizia vera è complessa, stratificata, piena di zone grigie. E l’avvocato è il cartografo di quelle zone.
Chiunque abbia assistito a un processo lo sa: quello che si vede nei film è distante anni luce dalla realtà. Non ci sono arringhe drammatiche ogni mezz’ora, ma faldoni, sospensioni, articoli, eccezioni preliminari, questioni procedurali. L’avvocato è il tecnico che conosce quel labirinto. Ma, nella percezione pubblica, resta un illusionista svogliato: c’è, ma non si vede.
Tornando al nostro caso, nei giorni successivi alla sentenza, il giudice venne convocato al CSM per “verifiche disciplinari”. L’avvocato, invece, stava già lavorando a un altro caso. Nessuno lo cercò. Nessuno lo intervistò. Nessuno si chiese: ma com’è che quell’imputato ha preso solo sedici anni? Il lavoro difensivo, come spesso accade, venne archiviato con un’alzata di spalle.
Forse è tempo di cambiare narrazione. Di iniziare a raccontare i processi per quello che sono: non duelli tra bene e male, ma esplorazioni tecniche dentro le regole. E lì, proprio lì, l’avvocato non è solo presente. È fondamentale.
La prossima volta che sentiamo dire: “Il giudice ha deciso” con tono accusatorio o celebrativo, forse dovremmo chiederci: Ma chi gli ha fornito la strada per arrivarci? Chi ha piantato i segnali, scavato le gallerie, aperto il varco? Come si è articolato il ragionamento?
Probabilmente, era un fantasma con la toga.
Un fantasma che parlava per legge, non per show.
Leggi Anche: